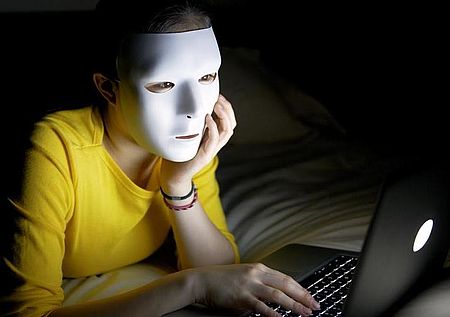Cari lettori, il mese di aprile per i milanesi è ormai sinonimo di arte e bellezza. Ogni anno infatti il centro della città si colora di eventi e istallazioni mozzafiato dando vita al cosiddetto Fuori Salone, una vera e propria mostra corale nata spontaneamente dalla volontà delle aziende del settore per celebrare il concomitante Salone internazionale del Mobile, il più importante evento di design e arredamento a livello mondiale allestito nella zona fieristica del capoluogo lombardo.
Quest’anno ho deciso di approfittarne per fare una visita alla meravigliosa Pinacoteca di Brera, una delle gallerie d’arte antica e moderna più importanti d’Italia situata nell’omonima centralissima via, dove è stata allestita forse l’installazione più iconica di questa edizione, ossia la “Library of Light”, un’imponente libreria di luce circolare con un pavimento rotante curata da Es Devlin (Kingston upon Thames, Regno Unito, 1971, all’anagrafe Esmeralda Devlin), autrice di fama mondiale per i suoi applauditissimi dispositivi scenici, come il cubo mobile immaginato per la tournée teatrale della Lehman Trilogy e il padiglione della Gran Bretagna all’expo di Dubai, incentrato su un futuristico dialogo tra poesia e intelligenza artificiale.
La maestosa scultura, arricchita dai 2000 volumi presenti nei suoi scaffali messi a disposizione dall’editore Feltrinelli, sarà visibile nel Cortile d’Onore della Pinacoteca, dove campeggia stabilmente il noto Monumento di Napoleone I ideato da Antonio Canova, fino al 21 aprile con l’obiettivo di celebrare la diversità e l’empatia nei confronti dei nostri simili e del mondo che ci circonda, una connessione che la nostra società sta a poco a poco dimenticando, così come ha dichiarato la stessa designer britannica:” In qualità di umano, uno dei miei timori è la potenziale estinzione della capacità di vedere attraverso gli occhi degli altri. I libri sono gli sguardi altrui, e lo spazio che li ospita, luoghi in cui immaginare la cura. Se non facciamo nostro questo pensiero, siamo davvero in pericolo. Ho sempre percepito le biblioteche come luoghi silenziosi, ma intensamente vibranti, dove menti e immaginazioni si librano in volo, trattenute come aquiloni dai corpi seduti che le ospitano. Questa scultura cinetica rappresenta le connessioni sinaptiche che si intrecciano, le risonanze e le associazioni che prendono vita nella mente di una comunità temporanea di lettori. Il moto è solo un modo per ricordarci quello che continuiamo a dimenticare: che siamo tutti sempre in movimento. Abituati a osservare la realtà da un unico punto di vista…”
Nei giorni del Salone l’installazione è anche il palcoscenico di una serie di incontri con artisti, curatori e scrittori vari, ma io ho preferito iniziare subito il tour dello spettacolare museo che si trova al piano superiore di questo gigantesco palazzo di oltre 24.000mq, uno dei complessi più grandi dell’intera metropoli, che oltre alla Pinacoteca ospita l’Accademia di Belle Arti, l’Osservatorio astronomico, la Biblioteca Nazionale Braidense, l’Orto Botanico e l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Fu fondato nel 1776 per volere di Maria Teresa d’Austria (al tempo la Lombardia faceva parte dell’impero austroungarico) con l’intento di formare artisti, architetti e intellettuali in un luogo dove studio e ispirazione potessero convivere. La galleria nacque inizialmente come collezione didattica, a servizio degli studenti dell’Accademia, ma con l’arrivo di Napoleone Bonaparte cambiò volto e vocazione. Fu infatti durante l’epoca napoleonica, a partire dal 1809, che la Pinacoteca si trasformò in un vero e proprio museo pubblico. Seguendo il modello del Louvre, Napoleone volle creare a Milano un grande centro espositivo capace di celebrare il potere e la gloria dell’impero attraverso l’arte. Le soppressioni degli ordini religiosi e le requisizioni napoleoniche permisero l’acquisizione di un vasto patrimonio artistico. Le opere migliori vennero spedite a Parigi, ma tanti altri prezzi preziosissimi come pale d’altare, opere rinascimentali, capolavori fiamminghi e veneti trovarono casa proprio qui, tra i chiostri e le aule dell’ex convento degli Umiliati. Alla caduta dei francesi, la Pinacoteca tornò in possesso degli Asburgo e nel 1882 venne separata dall’Accademia. Dopo le devastazioni dei due conflitti mondiali, necessitò di un lungo e delicato processo di ricostruzione e rinascita con cui prese forma un nuovo corso, più consapevole e riflessivo, teso a restituire al museo non solo il suo splendore architettonico, ma anche una missione culturale più ampia.
Negli anni ’50 e ’60 la Pinacoteca riprese pienamente la sua funzione di istituzione culturale nazionale, arricchendosi di nuove acquisizioni e ampliando il proprio sguardo all’arte del Novecento. Il museo, pur restando fortemente legato alla tradizione rinascimentale e barocca, cominciò ad accogliere opere moderne e contemporanee, avviando un dialogo tra epoche e sensibilità artistiche differenti.
Una svolta significativa è avvenuta con l’arrivo alla direzione di James Bradburne nel 2015. Con la sua visione internazionale e innovativa, Brera ha conosciuto una nuova stagione: l’allestimento delle sale è stato completamente ripensato, le didascalie sono diventate veri e propri racconti narrativi, e il museo ha iniziato a proporsi come spazio di incontro e partecipazione. Le tele sono state ricollocate secondo criteri tematici e cronologici che stimolano un’esperienza immersiva, pensata per coinvolgere anche il visitatore meno esperto.
Per quanto riguarda le opere, se si fa eccezione per il grande gesso di Antonio Canova raffigurante Napoleone in veste di Marte, sono tutte esclusivamente pittoriche e, attraverso un percorso espositivo di 38 sale, spaziano dalle scuole medioevali gotiche e tardogotiche di artisti come Giovanni da Milano, Gentile da Fabriano, Jacopo Bellini e Ambrogio Lorenzetti, fino alle avanguardie novecentesche di Carrà, Modigliani, Morandi, Sironi e De Pisis. Nel mezzo capolavori di fama mondiale del Rinascimento di Mantegna, Bellini, Raffaello, e Piero della Francesca; del Manierismo e del Barocco dei fratelli Carracci, Reni, e Caravaggio; del Romanticismo e divisionismo di Pellizza da Volpedo e Hayez fino a quelli dei macchiaioli Lega, Segantini e Fattori.
Oggi, la Pinacoteca di Brera non è solo un museo, è un laboratorio culturale, un luogo di sperimentazione e di memoria, capace di raccontare non soltanto la storia dell’arte, ma anche quella dell’Italia, dei suoi passaggi storici, delle sue ferite e delle sue rinascite. Camminare tra le sue sale significa compiere un viaggio non solo estetico, ma anche etico e civile. Ogni opera custodita qui è testimone di un’epoca, di un’ideologia, di un’evoluzione dello sguardo umano sul mondo. Situata nel cuore pulsante di una città che corre senza sosta, Brera resta un punto fermo che ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità, uno spazio di silenzio sospeso nel tempo capace di restituire all’arte la sua funzione più autentica: farci ricordare, sentire e riflettere.