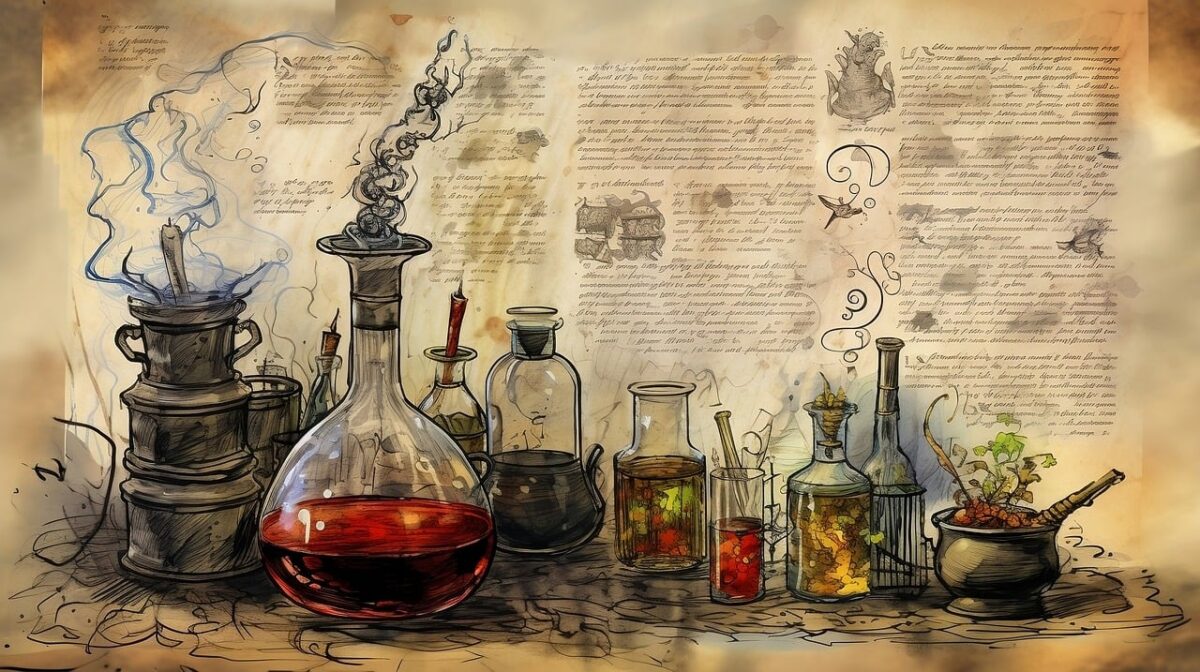Quando si pensa alla figura della donna medievale, la fantasia comune rimanda a un’immagine sobria e dimessa: un corpo nascosto da tuniche ampie, un volto privo di trucco, un atteggiamento devoto e docile, totalmente assoggettato all’autorità maschile e ai dettami religiosi. Ma questa visione è, almeno in parte, fuorviante.
La realtà del Medioevo, soprattutto per le donne dei ceti più alti, era infatti caratterizzata da un’ossessione sorprendente per l’estetica e per la cura della propria persona, tale da spingere molte a sottoporsi a pratiche estreme, invasive e persino tossiche pur di aderire a modelli di bellezza rigidissimi. Essere belle non era una frivolezza, ma un obbligo morale e simbolico, legato al prestigio della famiglia, al matrimonio, alla posizione nella corte. In tempi in cui la medicina era ancora assai approssimativa e la scienza chimica vista quasi come una sorella della stregoneria, gli unguenti di bellezza si trasformavano facilmente in veleni deleteri.
La Chiesa provava in ogni modo a frenare la vanità femminile etichettandola come una tentazione del demonio e i precetti cristiani scoraggiavano l’uso del trucco e la cura eccessiva del corpo. Ma il desiderio di bellezza, si sa, è una forza a cui difficilmente il gentil sesso riesce a rinunciare.
Così, accanto ai sermoni contro la lussuria, proliferavano trattati di bellezza scritti da medici e speziali. Uno fra tutti, il preziosissimo “De Ornatu Mulierum”, attribuito alla medichessa salernitana Trotula de Ruggiero, vera pioniera della cosmesi femminile. In esso si trovano consigli per ogni parte del corpo: come levigare la pelle, sbiancare i denti, eliminare le rughe, curare l’alito e persino come rendere più profumati i piedi!
Per aderire agli standard estetici del tempo, serviva dedizione, pazienza e una certa propensione al martirio! Il modello ideale di bellezza prevedeva un volto pallido, quasi diafano, simbolo di nobiltà perché implicava la possibilità di stare all’ombra e dunque di non abbronzarsi volgarmente come chi lavorava sotto il sole (Eleonora d’Aquitania, regina di Francia e poi d’Inghilterra, era invidiata ed elogiata da tutti proprio per la sua pelle lattea). Per ottenerla, si faceva uso di creme sbiancanti a base di piombo, aceto e miele, con effetti devastanti sul lungo periodo poiché deturpavano la pelle e provocavano macchie, piaghe e malattie degenerative. Stessa cosa dicasi per il collo: niveo e lucente era considerato sinonimo di giovinezza e salute. Le donne ci spalmavano miscele di arsenico e mercurio, oppure applicavano sanguisughe per far defluire, e quindi “purificare”, il sangue, ottenendo così un incarnato più chiaro a seguito di vere e proprie emorragie! Solo le guance potevano avere un tocco rosato, ottenuto con polvere di zafferano o con polveri argillosa stemperate in acqua e minio…una sorta di blush ante litteram!
La fronte doveva essere alta, amplissima, segno di intelligenza e raffinatezza (celebre il caso di Isabella di Francia, regina consorte d’Inghilterra, ritenuta la più bella del tempo per la sua “fronte ampia e nobile”). Per riuscire ad averla, le donne si rasavano la parte alta dell’attaccatura dei capelli. In certi casi si applicava un composto a base di calce viva e solfuro d’arsenico (lo stesso usato per facilitare la decomposizione dei cadaveri) che faceva cadere i capelli e gonfiava la pelle della fronte, provocando non poche conseguenze sulla salute.
Le sopracciglia venivano spesso eliminate del tutto o ridisegnate finissime con carboncino e cenere, mentre gli occhi, ritenuti affascinanti se grandi e chiari, erano resi più magnetici instillando nelle pupille gocce di Atropa belladonna, una pianta velenosa che dilatava lo sguardo, ma poteva col tempo compromettere la vista conducendo perfino alla cecità totale. Le labbra erano preferibili piccole e sottili, il naso dritto e delicato.
Ma se questi vi sembrano canoni ideali assurdi, state a sentire quelli ancora più sconvolgenti riguardanti il corpo!
Lo preferivano robusto, con fianchi stretti ma ventre prominente! Sì sì, avete capito bene, parlo proprio della pancia! Nel Medioevo, la pancia florida era segno di fertilità e benessere. Alcune donne più magre arrivavano a indossare persino imbottiture sotto il vestito per apparire più “piene”. Il seno, al contrario, non era considerato sensuale ma quasi una vergogna: si usavano corsetti strettissimi per appiattirlo il più possibile. Altro che mastoplastiche di oggi! Era considerato una parte volgare, poco armoniosa e nessuna al tempo avrebbe mai lontanamente pensato di valorizzarlo o ingrandirlo come facciamo noi!
Molto apprezzati erano invece i polpacci torniti e i piedi che, al contrario, dovevano essere piccoli e curati.
Per quanto concerne le acconciature, il prototipo mediterraneo dalle tinte scure tanto in voga oggi, non era così amato! Uno dei più gettonati standard di bellezza infatti era proprio il capello biondo, associato alla purezza angelica (dote quest’ultima che certamente non apparteneva alla perfida Lucrezia Borgia, dotata però di una chioma dorata per cui persero la testa centinaia di uomini!). Le donne italiane, per emulare le chiare tonalità delle germaniche, si schiarivano i capelli con impacchi a base di zafferano, tuorlo d’uovo, corteccia di sambuco e fiori di ginestra. Se il risultato non era soddisfacente, si ricorreva ai “posticci”: vere e proprie extension artigianali ottenute tagliando i capelli biondi ai paggi e poi cucite su retine o acconciature. Le mode variavano a seconda dell’epoca e del ceto chiaramente. All’inizio del Medioevo infatti, le donne dovevano coprire i capelli con veli e cuffie. Più tardi si cominciò invece a mostrarli con fierezza: raccolti in elaborate trecce dette “coazzoni” o lasciati sciolti sotto diademi e veli decorativi.
La depilazione era una vera e propria tortura anche a quei tempi! Le donne medievali si depilavano con cerette a base di calce viva e arsenico, miscele caustiche dal colore giallognolo che venivano riscaldate fino a diventare quasi incandescenti. Come potrete immaginare il dolore era intenso e le ustioni comuni. Chi non sopportava il dolore della ceretta, si affidava a un metodo ancora più invasivo: l’inserimento di aghi roventi nei bulbi piliferi per bruciare il pelo alla radice.
Dopo la depilazione, come se non bastasse, per rendere la pelle levigata e uniforme, si usavano scrub a base di segatura di legno e frammenti di vetro, massaggiati sul corpo da professioniste della bellezza, spesso convocate direttamente nelle case nobiliari.
L’estetica orale era un’altra priorità, ma i metodi quantomeno discutibili! La dentatura doveva essere candida e in assenza di dentifricio e sbiancanti chimici moderni, i trattati medici dell’epoca, come il “Compendium medicinae” del medico inglese Gilberto Anglicus, consigliavano di strofinare denti e gengive con un panno di lino, seguito da sciacqui con acqua pulita, aceto o vino. In caso di sporco eccessivo, venivano proposti rimedi come il sale, o una pasta abrasiva a base di urina di fanciullo mescolata con pomice, marmo grattugiato o ossa polverizzate…con effetti sullo smalto a dir poco abrasivi! Per mantenere l’alito fresco si masticavano erbe aromatiche, mentre per nutrire e ammorbidire le mani durante la notte si indossavano guanti imbottiti di miele e mostarda, non propriamente comodi ma garanti di un risultato eccellente.
La pulizia quotidiana era rara e guardata con sospetto. La Chiesa condannava i bagni pubblici, considerati luoghi di malattie, peccato e prostituzione. Stessa cosa dicasi per l’acqua, considerata nociva, poiché si credeva potesse disturbare l’equilibrio umorale, penetrando nei pori della pelle e rendendo il corpo vulnerabile alle malattie.
Ci si lavava integralmente solo in rare occasioni, ad eccezione di mani viso che, al contrario, venivano puliti ogni mattina, spesso dopo essersi vestiti, utilizzando acque profumate con erbe o acqua di rose importata dall’Oriente.
Lo shampoo era fatto con sostanze vegetali, mischiate a zolfo o acquavite, e per il corpo si usavano inizialmente farina di fave o soda. Il sapone vero e proprio, giunto in Europa, soprattutto in Francia, attorno al IX secolo, inizialmente era morbido, con scarso potere detergente. Attorno al XII secolo, cominciarono a circolare saponi più solidi, preparati con grasso di montone, cenere di legna o potassa e soda naturale, spesso arricchiti con erbe aromatiche, o in altre varianti con olio di oliva e cedro.
Insomma, dietro l’apparente austerità dell’iconografia medievale, si nascondeva un mondo sorprendentemente sofisticato, in cui la bellezza femminile non era solo vanità, ma anche potere, simbolo, linguaggio. Un codice silenzioso che parlava di rango, virtù, desideri e obblighi. E sebbene molte delle pratiche dell’epoca ci appaiano oggi barbare o grottesche, non sono poi così lontane dalle ossessioni chirurgiche contemporanee. Come ieri, anche oggi, l’estetica continua a essere il campo di battaglia su cui si giocano norme sociali, morali e culturali. Cambiano i canoni, le tecniche si sono evolute, ma resta identica la pressione a cui è sottoposto il corpo della donna: modellato, controllato, giudicato.
Guardare al passato, allora, non deve essere solo un esercizio di curiosità storica, ma anche un’occasione per interrogarci sul presente e su quanto, davvero, siamo disposte a patire, o a sacrificare, in nome del compiacimento sociale. Perché cambiano i secoli, ma la bellezza, quella imposta, quella inseguita, quella sofferta, resta una forma sottile di potere. E, troppo spesso, di silenziosa prigionia.